Maestà di Santa Trinita, opera di Cimabue
La “Maestà di Santa Trinita” (1280), realizzata da Cimabue per la chiesa di Santa Trinita di Firenze, patì gli esiti di vicende complesse, legate alle vicissitudini della chiesa ospitante e di una nicchia culturale di estimatori forse troppo tardiva. La complessità delle opere di Cimabue colpisce ogni tipo circostanza analitica, stagliandosi nell’orbita di un’emozionalità connaturata nello spirito religioso del motivo della reale e sacra figura madonnale accompagnata dal Bambino.

Nella completa comprensione del Trecento fiorentino, quale proscenio di lunghe e fulgenti rinascite artistiche, è facile dedurre il ruolo anticipatore di un’ arte non più rigidamente bizantina, ma nata progressivamente dalle intuizioni dei grandi protagonisti della Firenze guelfa e ghibellina.
Anche questa volta la Galleria degli Uffizi di Firenze si raffigura come luogo sacro alla custodia di un ennesimo capolavoro artistico, nell’uso di direttive espositive volte a far emergere le sottili linee evolutive che raffrontano la tabula cimabuesca con la “Madonna Rucellai” (1285) di Duccio di Buoninsegna e la “Maestà di Ognissanti” (1310) di Giotto.
Genesi dell’opera
Nell’attenta analisi cronologica e tecnica dei “primitivi” senesi e fiorentini, emerge il netto contrasto, in termini valutativi, grandemente operante nel contesto dotto dell’opera di committenza delle grandi cerchie religiose nei confronti di un avanguardismo pittorico nascente, e di un apprezzamento tardivo rispetto alla tangibile pregevolezza dell’opera.
I grandi capolavori di Cimabue subirono, in via quasi del tutto esclusiva, una sorte favorevole, in una completa combinazione tra il riconoscimento dell’ingegno tecnico e la conseguente approvazione da parte del pubblico contemporaneo. Un’eccezione affiora proprio dallo studio dei percorsi che legano la pala lignea della Maestà di Santa Trinita alle varie collocazioni, a partire dal periodo successivo alla sua destinazione originaria:
Avendo poi preso a fare per i monaci di Vall’Ombrosa nella badia di Santa Trinita di Fiorenza […] la qual tavola finita fu posta da’ quei monaci in sull’altar maggiore di detta chiesa, donde essendo poi levata, per dar quel luogo alla tavola che v’è oggi di Alesso Baldovinetti, du messa in una cappella minore della navata sinistra di detta chiesa. (Vasari)
Da questo breve estratto vasariano sembra che al momento della sua realizzazione, la “Maestà di Santa Trinita” di Cimabue, dopo la prima fase di consenso, avesse perso il fascino nativo del dorato culto ieratico della Madonna col Bambino al di là della “maniera” bizantineggiante, almeno fino al 1471, quando venne crudelmente rimpiazzata dalla “Trinità con San Benedetto e San Giovanni Gualberto” del fiorentino Alesso Baldovinetti, per raggiungere le infauste sorti di una collocazione di minore influenza in cappelle di ordine secondario o addirittura destituita ad opera di manchevole fattura all’interno dell’infermeria del monastero.
La tabula lignea della “Trinità con San Benedetto e San Giovanni Gualberto”, realizzata per la famiglia Gianfigliazzi, nelle persone di Messer Giovanni e Messer Gherardo, testimonia agli occhi dei critici moderni il venir meno delle capacità immaginative dell’artista fiorentino, raffigurandosi, di fatti, come opera comparativa di forte contrasto rispetto all’ingiusta sorte toccata alla pala cimabuesca, quale cardine primo nell’esatta funzione di superamento della “scabrosa, goffa e ordinaria […] maniera greca (bizantina)“.
Il ruolo dei “primitivi”, che, nel paradigma storiografico rinascimentale, avevano precorso Michelangelo Merisi, Raffaello Sanzio e gli altri grandi esponenti del Cinquecento italiano, subì un’incredibile riconsiderazione tra il Settecento e l’Ottocento, grazie all’opera dei grandi collezionisti europei e nostrani; tale atteggiamento rivalutativo destò la sopita attenzione verso l’ormai dimenticata pala di Cimabue che, nel 1810, raggiunse l’Accademia fiorentina, per variare nuovamente destinazione un secolo dopo, con la disposizione dell’attuale allestimento dei “primitivi“, nella Galleria degli Uffizi.
Maestà di Santa Trinita: note tecniche e descrittive
La “Maestà di Santa Trinita” risulta essere, più del “Crocefisso” rovinato di Santa Croce, l’opera più remota dell’artista “tirato dalla natura“, la cui
unica data sicura nel Duecento, al 1272 a Roma, senza essere collegata a nessuna opera, ci pone di fronte a una pittura che quasi nasce di colpo, armata come Minerva dalla testa di Giove.
(Brandi).
Anche nell’ingegnosa considerazione che tale pala dovesse seguire gli affreschi superiori della Chiesa di Assisi – terminati nel 1283 – si dovrebbe porre la genesi di tale capolavoro in un periodo antecedente il 1285, ovvero alla fase di realizzazione della “Madonna Rucellai” da parte di Duccio di Buoninsegna, che in maniera evidente segue l’esempio ligneo e non precede la sublime Maestà di Cimabue.
L’opera attesta una fase compiutamente matura del pittore fiorentino che, in un’armoniosità lontana dallo stile di Coppo di Marcovaldo e della pittura paleologa, portò in sé, per la prima volta, un’evoluzione stilistica e una pienezza riscontrabili solo nella Maestà della Chiesa inferiore di San Francesco di Assisi, nella “Maestà di Santa Maria dei Servi“, nella Maestà pisana del Louvre (1280) e nel San Giovanni a mosaico dell’abside del duomo di Pisa, dove si assiste all’attenuazione delle aspre regioni facciali tipiche di Cimabue; tale alterazione lascia pensare ad un adeguamento all’arte di Duccio di Buoninsegna nell’uso del colore, sia al codice giottesco relativo all’uso dei trapassi luminosi e levigati.
Nella tabula di Santa Trinita, la solennità del trono architettonicamente emergente dal fondo oro s’impone immediatamente alla vista dell’osservatore, “al punto che, più che una pittura, sembra quasi la facciata di una cattedrale” (BRANDI).
L’immagine ieratica si presenta solidamente frontale, rigidità rigorosa che si interrompe solo nel momento sacro in cui la Madonna ripiega delicatamente il viso indicato l’infante Redentore.
Il trono, contrariamente a ciò che si assiste nella “Maestà di Parigi” e nella “Madonna Rucellai”, risulta essere grandiosamente frontale, incurvandosi nella parte centrale, piuttosto che avanzante sul suppedaneo.
Questa serie di dettagli tecnici designano l’immensa abilità dell’artista di effettuare una rigenerazione dei vecchi schemi, come si configura appunto quello frontale; talento riscontrabile nella stessa capacità di traslare il chiaroscuro paleologo da “semplice oggettivazione dell’immagine a robusta espressione plastica del volume” (BRANDI), in una complessa e insigne monumentalità ravvicinante alla figura di Giotto, anche se dal punto di vista del codice formale la pittura di Cimabue sia lontanissima da quella di Giotto.
Un’altra caratteristica degna di nota è lo straordinario uso delle bizantine gradazioni cromatiche sulle ali degli angeli che, in questo frangente, assumono una funziona differente che in Pietro Cavallini, conferendo quella funzionalità plastica modulante i volti e le pieghe prismatiche dei vestiti.
La sacra raffigurazione è espressa secondo un preciso e fondamentale registro volumetrico, dato da una spazialità caratteristica, quale etere da cui da cui si sviluppa l’immagine e non quale luogo contenente l’immagine.
E’ interessante notare come nel piedistallo del trono delle striature auree tendano a convergere verso un unico punto, allo stesso modo il piedistallo genera al centro un’ esedra concava che indirizza sul piano posteriore la composizione.
Nelle altre Maestà il suppedaneo svolgeva una funziona differente, verticalizzando la composizione sull’orlo del quadro piuttosto che protrarla avanti.
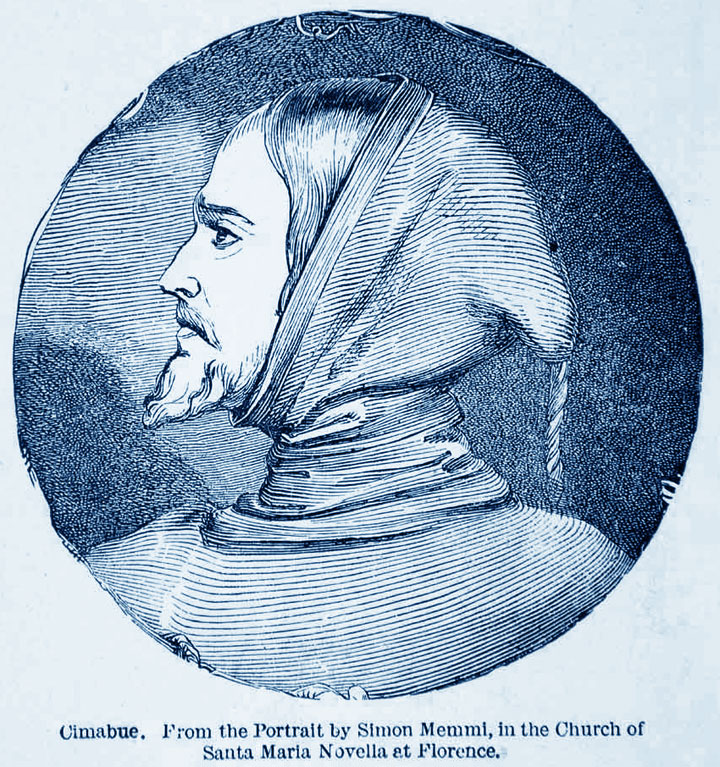
Appare evidente quanto la sottigliezza gotica del trono della Madonna Rucellai abbia influenzato la spazialità di Cimabue, esibendo un’idea di spazialità retrostante all’immagine, in cui l’immagine emerge nei suoi volumi corposi.
L’enfasi della cromaticità plastica delle ali è confermata dall’universale uso di una tonalità bassa nel dipinto, in cui, a parte il profeta David, tutti gli altri colori sono sottotono.
Non è dunque un’opera bizantina nell’uso dei colori, ma si configura come l’esaltazione di un tema plastico già trattato da Nicola Pisano, e che si rivelerà fondamentale come retroscena di Giotto.
Note Bibliografiche
A. Tomei, Cimabue, Giunti Editore, Firenze, 1997
C. Brandi, Scritti d’arte, Bompiani, Milano, 2013
G. Vasari, Le opere di Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, Davide Passigli e soci, Firenze, 1832 – 1838
